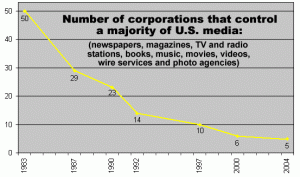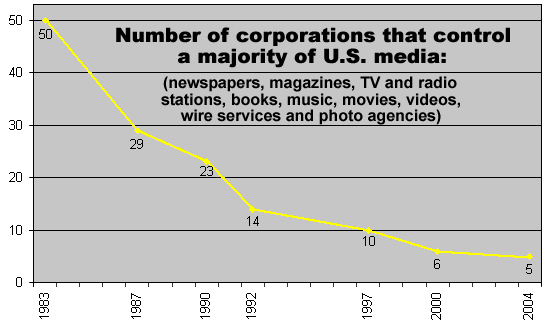
La stampa come ‘’bene comune’’: perché è importante il sostegno pubblico all’ editoria
Novanta giornali sull’orlo del fallimento. Finanziamenti ancora incerti e un disegno di legge delega sull’editoria gravemente lacunoso. Torna di attualità la questione del sostegno pubblico all’ editoria, dopo l’allarme lanciato da Franco Siddi (Fnsi), sul rischio chiusura per tante testate italiane.
Riproponiamo un’ analisi di Carlo Gubitosa, dedicata in particolare ‘’agli amici che difendono strenuamente tanti ‘beni comuni’, ma pensano che la stampa non sia un bene comune e vada abbandonata alle leggi di mercato tagliando ogni forma di aiuto pubblico’’. Il vero nemico – dice Gubitosa – sono le concentrazioni, non il sostegno pubblico alla cultura.
Caro amico “anticasta”, ti spiego perché l’editoria non può essere abbandonata al mercato dopo essere stata sequestrata dai partiti.
di Carlo Gubitosa
Appoggereste un movimento che vuole privatizzare i beni comuni? No, vero? Abbiamo lottato strenuamente per difendere dalle privatizzazioni e dalle speculazioni l’acqua pubblica, la scuola pubblica, la sanità pubblica e alcune reti di trasporto pubblico. Nei paesi dove la salute e l’istruzione sono diventati beni di consumo abbiamo una popolazione più malata e più ignorante, e i trasporti privatizzati sono più cari e meno capillari, come sa bene chiunque possa confrontare il servizio offerto dalle vecchie “Ferrovie dello Stato” (capace di raggiungere anche i borghi più sperduti), con quello attualmente offerto da “Trenitalia SpA”, che taglia i rami secchi e favorise l’alta velocità, le tratte ad alta percorrenza e i prezzi altissimi, rottamando a colpi di “Frecce” i vecchi treni interregionali, intercity, espressi e i “notturni” che hanno aiutato tantissimi emigrati del sud a passare il natale e la pasqua con le loro famiglie.
Ma c’è un bene comune che “il popolo dei referendum” non sembra intenzionato a difendere: l’editoria, che qualcuno vorrebbe abbandonare alle spietate leggi di mercato. E quando si dice “editoria” si parla di un contenitore che racchiude tantissimi altri beni comuni: la cultura, il pluralismo, la difesa delle minoranze, l’esercizio della libera espressione, la difesa delle voci più deboli, l’autodifesa dei cittadini dai monopoli dei grandi cartelli editoriali che condizionano la vita, l’economia e la politica del paese.
Un settore molto delicato, che è commercio e servizio pubblico al tempo stesso, luogo di profitto mercantile e luogo di nutrimento dell’anima, sfera pubblica e proprietà privata. E allora proviamo a ragionarci un pò sopra per capire come funziona questo settore.
Partiamo dai dati: gli Stati Uniti hanno più di 46 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, praticamente uno su sette, un record mai raggiunto finora, e secondo le recenti segnalazioni del “Guardian” sembra che le stime più recenti dell’US Census Bureau portino questo valore a 49 milioni. Alla faccia di chi pensa che il mercato si regoli da solo portando benessere per tutti.
La favola della “mano invisibile del mercato” che autoregola l’economia offrendo a tutti le stesse opportunità si è rivelata in molte occasioni per quello che è: un imbroglio bello e buono, ed è per questo che con la nostra cultura del “bene comune” ci vengono i brividi ad immaginare una società dove non ci sono servizi pubblici di pronto soccorso e la salute è completamente in mano alle leggi della domanda e dell’offerta.
Ma c’è qualcuno che ancora si ostina a credere alla stessa teoria riproposta in modo diverso: “lasciate i giornali sul mercato senza che lo stato ci metta un centesimo, che vinca il migliore e alla fine prevarranno i giornali più onesti, trasparenti e coraggiosi“.
Sarà vero?
Per capire se il “mercato libero” e senza intervento statale può essere il contesto migliore per favorire il pluralismo non c’è bisogno della sfera di cristallo con cui guardare il futuro, bastano un pò di informazioni e un pò di memoria per leggere il passato. Il grafico qui sotto spiega quello che è accaduto negli ultimi anni nella “Land of the free”, la terra a stelle e strisce degli uomini liberi, dove i grandi colossi mediatici hanno vissuto un processo di drastica concentrazione che nel giro di pochi anni ha ridotto del 90% il numero delle aziende che controllano la gran parte del mercato.
Nel 1983, 50 grandi “corporation” controllavano la grande maggioranza di tutti i mass media negli Stati Uniti. In quell’anno, il saggista Ben Bagdikian fu bollato come “allarmista” per aver descritto questo fenomeno nel suo libro “The Media Monopoly”. Nella quarta edizione del libro, pubblicata nel 1992, Bagdikian ha previsto che questo numero sarebbe sceso fino ad una mezza dozzina di compagnie, e anche questa previsione fu accolta con scetticismo. Nel 2000, quando è stata pubblicata la sesta edizione del libro, il numero dei “grandi attori mediatici” negli USA era sceso effettivamente a sei.
Nel 2004 Bagdikian dà alle stampe “The New Media Monopoly”, una edizione rivisitata ed espansa del suo best-seller, e nello stesso anno le grandi “corporation” che controllano la maggior parte dell’industria statunitense dei media si contano sulle dita di una mano: Time Warner, Disney, Murdoch’s News Corporation, Bertelsmann e Viacom.
Il settore di cui si parla non riguarda solo i libri e le pubblicazioni periodiche, ma è un enorme mercato che comprende quotidiani, riviste, stazioni radiofoniche e televisive, musica, film, video, servizi televisivi via cavo e agenzie fotografiche. Un enorme “moloch” che il libero mercato statunitense ha affidato alle decisioni di cinque consigli di amministrazione, che rispondono solo ai loro azionisti e non ai cittadini della “culla delle libertà”.
Ciò nonostante quando si tratta di dire “basta dare soldi ai partiti per fare giornali faziosi“, molti si fanno prendere la mano e dicono “basta dare soldi all’editoria, vogliamo la stessa stampa libera che c’è negli Stati Uniti dove chiunque può andare in edicola se fa un buon giornale”.
Ma questo non è vero, perché a dispetto del sogno americano che può trasformare un qualunque lustrascarpe nel proprietario di una catena di giornali, per chiunque sia estraneo a questi giochi di potere ci sono delle barriere all’entrata e delle economie di scala che penalizzano gli “outsiders”.
In altre parole, è molto più facile fondare una nuova testata per la News Corporation di Murdoch che per un qualunque altro imprenditore (barriere all’entrata), una piccola casa editrice tematica ha dei costi di produzione per ogni singola copia di gran lunga superiore a quelli di un colosso editoriale (costi marginali più alti), i libri degli editori indipendenti sono ignorati, mentre ogni nuova uscita di un grande gruppo editoriale può contare sulla promozione gratuita di tutte le altre testate del gruppo (sinergie di marketing).
Le cose scritte tra parentesi sono le vere “leggi di mercato”, quelle che si studiano in università, e sono le stesse leggi che ci permettono di dire con un buon grado di certezza che ogni mercato editoriale completamente abbandonato dall’intervento correttivo del settore pubblico si trasforma in un oligopolio impermeabile all’ingresso di nuovi soggetti, dove si uccide il pluralismo e si produce una “cultura di plastica” che dà spazio solo alle voci più forti, affermando uno scenario dove anche i consumi “alternativi” di cultura sono comunque ristretti in un ventaglio di opzioni ben determinato.
Questo è quello che accade in un mercato come quello statunitense, dove si producono libri per centinaia di milioni di potenziali lettori, nella lingua che è la prima al mondo per diffusione e la terza per numero di madrelingua dopo il cinese e lo spagnolo, un mercato dove le potenzialità commerciali sono infinitamente più grandi di quelle che abbiamo nel nostro piccolo paese da sessanta milioni di abitanti con dieci milioni scarsi di lettori abituali e una media di lettura tra le più basse in Europa, con il 44% degli abitanti che legge tre libri all’anno o meno, e regioni come la Sicilia dove a detta dell’Istat il 20% delle famiglie non ha libri in casa. Ripeto: non ha libri in casa.
Facendo le debite proporzioni tra noi e gli Stati Uniti, possiamo capire che l’abbandono di un settore relativamente piccolo e assolutamente debole come quello della carta stampate alle regole di un mercato predatorio rischia di creare in Italia delle forme di concentrazione ancora più odiose e soffocanti di quelle che si sono sviluppate negli USA.

E infatti osservando la situazione nostrana si può capire come il fenomeno della concentrazione mediatica (che è il vero male da combattere) sia giunto ad uno stato più che avanzato anche nel nostro paese, per nulla mitigato da un intervento statale mai orientato verso il pluralismo, e sempre espressione dei rapporti di forza tra partiti e lobbies. Ecco qui alcuni dati, pubblicati sul numero 3 della rivista Mamma! nell’inchiesta “A chi vanno i soldi che spendiamo in edicola?”
Quello dell’editoria italiana è un mercato da quasi 5 miliardi di euro (nell’articolo si parla di “4927 miliardi, ma in realtà all’epoca ci è saltata una virgola, ed erano 4,927 miliardi) dove cinque società per azioni controllano il 71% del settore: Rcs Editori Spa (21,3%), Gruppo Editoriale L’Espresso (18,6%), Mondadori (18,3%), “Il Sole 24 Ore Spa” (10%), Caltagirone Editore (4,9%).
Nell’articolo scrivevamo anche che “l’antidoto migliore a questa concentrazione di potere e di giornali” è “sapere a chi si danno i soldi quando si compra un giornale e premiare la piccola editoria indipendente non controllata dalle cinque sorelle della carta stampata”.
Se leggendo tutto questo hai capito che l’editoria è un bene comune da difendere contro gli accaparramenti e le concentrazioni mediatiche così come abbiamo difeso l’acqua pubblica dagli accaparramenti delle multinazionali dell’acqua, allora ti invito a proseguire per passare dall’analisi della situazione alla sintesi di alcuni principi condivisi. Altrimenti, se sei ancora convinto che neppure un centesimo della spesa pubblica debba essere destinato a misure che tutelano le voci più deboli dell’editoria e della cultura, e pensi che la soluzione migliore per la stampa sia un mercato completamente deregolato senza alcun intervento pubblico realizzato a nome dei cittadini e nel loro interesse, puoi tranquillamente lasciar perdere le considerazioni che seguono.
Bene. Se stai leggendo ancora vuol dire che ritieni condivisibili in tutto o in parte le considerazioni sulle peculiarità del mercato editoriale, sulla specificità dell’editoria italiana e sull’importanza di un intervento pubblico che sia orientato dai cittadini, libero dai condizionamenti dei partiti e dei grandi editori. A partire da queste considerazioni di natura generale, provo a tracciare alcuni principi che partono da convinzioni personali:
1 – La cultura e l’informazione non possono essere totalmente abbandonate alla sfera del mercato, perché dove questo è avvenuto il risultato non è stato il moltiplicarsi delle voci e il fiorire dell’editoria libera, ma la concentrazione editoriale e la creazione di oligopoli e monopoli di fatto, che creano fortissime barriere all’entrata per i soggetti nuovi che hanno qualcosa di diverso da dire.
2 – La cultura e l’informazione vanno sottratte all’indebita ingerenza dei partiti e delle lobbies come Confindustria e la Cei, che hanno monopolizzato questo settore a proprio esclusivo beneficio utilizzando i fondi per l’informazione pubblica per finanziare le proprie campagne di propaganda privata.
3 – I criteri di sostegno alle iniziative editoriali devono essere stabiliti dai cittadini con meccanismi aperti e trasparenti, e non dai partiti con meccanismi clientelari.
4 – I finanziamenti ai quattro più grandi gruppi editoriali italiani (che hanno le spalle abbastanza larghe per stare sul mercato da soli, soprattutto se alle spalle hanno il Vaticano, Confindustria o i Partiti Politici) vanno immediatamente azzerati per favorire il pluralismo.
5 – Il sostegno pubblico garantito dai cittadini alla cultura “fuori mercato” va indirizzato a beneficio delle tante iniziative di microeditoria, riviste locali, radio e tv comunitarie, librerie di quartiere e tante altre migliaia di piccole voci che sono la vera ricchezza culturale del paese, e che per le loro dimensioni non riuscirebbero a stare “sul mercato” raccogliendo abbastanza audience, pur rappresentando un indispensabile complemento all’editoria di massa, alle testate nazionali, ai network radiotelevisivi e alle grandi catene librarie.
6 – L’intervento pubblico a correzione delle distorsioni del mercato può trasformare quelli che fino a ieri erano finanziamenti a fondo perduto in un investimento capace di creare ricchezza nel paese, rendendoci più istruiti grazie ad un settore editoriale più pluralista, dove i giornalisti non sono abbandonati alle prepotenze dei grandi editori e possono avviare più facilmente nuove iniziative autonome, senza che debba intervenire un nuovo Principe Caracciolo a finanziare gli Scalfari del terzo millennio.
Se mi hai seguito fin qui, e concordi con questi principi, ecco una possibile proposta concreta: L’OPZIONE FISCALE.
L’opzione fiscale è uno strumento che toglie potere ai partiti e lo consegna ai cittadini, rendendoli liberi di scegliere come sara’ spesa o come non si potra’ spendere una parte delle loro tasse.
Chi pensa che si debbano azzerare i finanziamenti all’editoria lo farà per la sua quota parte segnalando le sue intenzioni nella propria dichiarazione dei redditi, chi invece pensa che si debba finanziare una determinata testata indicherà in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’associazione, dell’azienda o dell’organizzazione che realizza una determinata iniziativa editoriale ritenuta degna di sostegno. In questo modo si ottiene l’effetto benefico di decentralizzare le risorse finora concentrate nelle mani dei partiti e di pochi avidi gruppi editoriali e al tempo stesso permettere ai cittadini di finanziare anche iniziative piccolissime qualora le ritengano meritevoli di sostegno, senza vincoli sulle copie vendute, sul bacino di utenza o su altri criteri puramente “numerici” e non indicativi del valore culturale di una iniziativa.
Il discorso dell’opzione fiscale potrebbe estendersi anche ad altri ambiti, e a quel punto ad ogni dichiarazione dei redditi potremmo conoscere quanti italiani vogliono finanziare le guerre all’estero, quanti vogliono finanziare la piccola editoria, e quanti vogliono invece uno stato che non faccia guerre nè cultura e preferiscono che i soldi siano destinati agli ospedali, alle carceri e ad altri tipi di iniziative.
Il meccanismo dell’opzione fiscale è simile a quello dell'”otto per mille” destinato alle organizzazioni religiose o al “cinque per mille” destinato alle associazioni, con la differenza che l’opzione fiscale per l’editoria potrebbe prevedere anche l’eventualità di una OBIEZIONE FISCALE, cioè l’azzeramento di quei finanziamenti da parte del singolo cittadino e il riconoscimento del diritto di esprimere una scelta dicendo “io non voglio finanziare questo settore di attività”, dirottando su altre spese pubbliche i soldi che sarebbero stati assegnati ai giornali, alle cosiddette “missioni di pace” o ad altre attività non imprescindibili per il funzionamento della cosa pubblica.
Il finanziamento di questi settori “non strategici” potrebbe essere affidato alle scelte espresse dai cittadini attraverso l’opzione fiscale, e il sostegno ritirato a certe attività non fondamentali (come ad esempio le missioni di pace all’estero) potrebbe essere dirottato su altre voci di spesa (ad esempio le forze di polizia tributaria per la lotta all’evasione fiscale) innescando delle spirali virtuose nell’economia nazionale.
Purtropppo nel ragionamento sull’opzione fiscale c’è un gravissimo difetto: apre uno scenario che è troppo democratico per i partiti, troppo dannoso per i grandi editori, troppo complicato per trasformarlo in uno slogan dei movimenti, troppo equilibrato per essere adottato da chi si trova a suo agio solo esprimendo posizioni massimaliste e populiste tagliate con l’accetta, troppo omnicratico e decentralizzante per essere adottato dal potere politico e da qualunque altro gruppo di potere organizzato che tende ad accentrare, controllare, dominare anche se a fin di bene.
Ma il fatto che ci siano degli obiettivi difficili non può farci chiudere gli occhi davanti alla possibilità di un altro mondo con un’altra editoria. Il fatto che sia molto ripida la salita del cammino che porta verso il disarmo, la nonviolenza, l’omnicrazia, la cultura diffusa e popolare, la libertà di pensiero e il pluralismo non può esimerci dal percorrere questa salita con l’intima persuasione che l’ingerenza dei partiti nell’editoria sia un male da evitare, ma senza abbandonare questo settore così delicato alla violenza predatoria del mercato che è un male ancora peggiore.
Nè dei partiti, nè dei padroni: la cultura, l’informazione e l’editoria devono essere controllate dai cittadini, finalizzati al bene comune e non al profitto o al tornaconto politico, governate da principi di apertura e non di selezione naturale tra le aziende più forti. Non siamo costretti a scegliere il male minore tra il potere statalista dei partiti e quello neoliberista dei consigli di amministrazione, ma abbiamo il diritto di progettare alternative e il dovere di informarci su tutte le alternative possibili.
E forse, quando avremo capito l’importanza che avevano i tratti di ferrovie locali dismessi da Trenitalia per questioni di redditività, riusciremo a capire anche l’importanza che possono rivestire in una società civile degna di questo nome dei pezzi di editoria sottratti al mercato, preziose “riserve indiane” di libero pensiero che andrebbero difese da tutti noi, anziché essere abbandonate alle insidie di un mercato dove per una presunta “autoregolazione” tutta da dimostrare alla fine la “cultura” di massa vince sulla buona editoria.