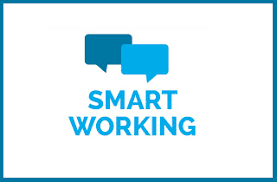
Per favore non chiamiamolo Smart Working
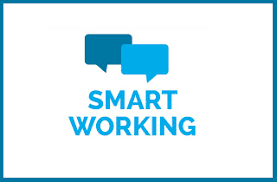 Più che una definizione da vocabolario serve, in questo caso a nostro avviso, comprendere quanto sia complesso questo termine e quanto stratificato sia l’atto che sta alla base della realizzazione pratica della funzione operativa che sostiene il “lavorare agilmente”. Non è successo – ed è importante sottolinearlo – che a causa della reclusione forzata in casa cui siamo stati tutti costretti dalla quarantena a causa dell’epidemia, ci siamo trasformati in “lavoratori agili”. E’ accaduto che non potendo andare al lavoro, siamo stati costretti ad utilizzare i nostri “portentosi” device tecnologici digitali, per provare a non smettere di lavorare, studiare, divertirci, comunicare, in una parola: vivere. Tornando allo smart working – quello vero – proviamo ad aggiungere notizie certe, estraendo informazioni, dalla definizione enciclopedica del termine o meglio della prassi in cui ci siamo forzatamente ritrovati:
Più che una definizione da vocabolario serve, in questo caso a nostro avviso, comprendere quanto sia complesso questo termine e quanto stratificato sia l’atto che sta alla base della realizzazione pratica della funzione operativa che sostiene il “lavorare agilmente”. Non è successo – ed è importante sottolinearlo – che a causa della reclusione forzata in casa cui siamo stati tutti costretti dalla quarantena a causa dell’epidemia, ci siamo trasformati in “lavoratori agili”. E’ accaduto che non potendo andare al lavoro, siamo stati costretti ad utilizzare i nostri “portentosi” device tecnologici digitali, per provare a non smettere di lavorare, studiare, divertirci, comunicare, in una parola: vivere. Tornando allo smart working – quello vero – proviamo ad aggiungere notizie certe, estraendo informazioni, dalla definizione enciclopedica del termine o meglio della prassi in cui ci siamo forzatamente ritrovati:
Smart working (lavoro ‘agile’): la possibilità di rompere grazie alla tecnologia e a una nuova mentalità l’unità di spazio e di tempo nel processo lavorativo. Orari flessibili e possibilità di lavorare in luoghi diversi sono esigenze che trovano attenzione non disinteressata delle aziende ma anche nella politica, posta di fronte al compito di dotare l’innovatività delle forme produttive di norme e di tutele.
Nel disegno di legge che dovrebbe riorganizzare il mondo del lavoro soprattutto autonomo sono previste specifiche misure normative relative al lavoro agile definito una «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».
Nel 2015 il 17% delle grandi imprese italiane ha già avviato dei progetti organici di Smart working, introducendo stabilmente nuovi strumenti digitali, una nuova e più flessibile organizzazione dell’orario, una modifica degli spazi; e si prevede che in un tempo relativamente breve il lavoro agile raggiungerà circa il 50% delle grandi aziende.
Naturalmente è difficile che questo passaggio a cui in qualche modo concorrono con i loro interessi e le loro aspirazioni lavoratori, imprese e istituzioni si sviluppi senza contraddizioni e senza conflitti anche aspri. Rimane però un nodo ineludibile per tutta la società.
Si tratta dunque di una risorsa e non di un limite. Un modo intelligente – “agile” appunto – e anche evoluto, di svolgere la propria attività. E allora come mai, adesso che abbiamo provato, nostro malgrado, in modo forzato ma anche con sicuro profitto, a lavorare da casa – non per davvero in smart working, certo – ma da remoto, usando i nostri ausili digitali, come mai non ci stiamo davvero evolvendo? Perchè molte voci, alcune anche autorevoli, si sono levate dissonanti e discordanti, chiedendo un ritorno – un ritorno? – al lavoro “vero”. Non fa strano anche a Voi, sentire qualcuno, parlare di questa modalità – utile e moderna – di intendere il lavoro, come se fosse un ripiego. Qualcosa di simile ad una toppa momentanea. Una specie di capitolo buio da associare – sbagliando – al momento davvero oscuro e difficile che abbiamo vissuto e stiamo ancora in parte vivendo, noi tutti, l’epoca della pandemia? Come sempre accade, non saremo noi a fornirVi le risposte – non ne siamo all’altezza – proveremo invece a chiamare in causa alcune voci, estraendo alcuni contributi da una sorta di “rassegna stampa” sul dibattito, che abbiamo provato a comporre in questi giorni. Intanto ci piace molto una definizione sul tema che ha dato uno dei nostri “collaboratori” più solerti, che oltre ad essere uno studioso di politica ed economia, è anche un imprenditore di successo:
Isolaworking suonerebbe più realistica come definizione. Cosa ci sia di smart – e dunque di positivo per definizione – è facile da vedere. Quali conseguenze concrete e reali avrà sulla nostra vita, è molto più difficile da prevedere, soprattutto sul medio-lungo periodo. Ad esempio sul processo formativo continuo che avviene nei team di lavoro “in presenza” e che – al momento – rimane l’unica strada attuale di crescita professionale, nonchè di accumulo di conoscenze aziendali.
Formazione, cultura, conoscenza condivisa, alfabetizzazione digitale, studio e comprensione della complessità; sono alcune delle regole ferree a cui dovremmo attenerci per poter applicare una nuova cultura al lavoro e farlo diventare davvero “agile”. Senza trascurare i diritti e i doveri dei lavoratori di ultima generazione. Agile non può ovviamente significare “schiavo”, ma nemmeno disinteressato e disimpegnato. In altre parole, stiamo entrando in una dimensione del lavoro diversa da quella precedente, e che deve essere completamente studiata e nuovamente codificata, prima di essere realizzata. E questa full immersion  forzata, cui siamo stati tutti costretti, ora che abbiamo nuovamente la possibilità di scegliere, non deve trasformarsi in una parentesi inutile e dannosa, bensì, in una utile fase di laboratorio da cui ricavare indicazioni importanti per realizzare un vero “upgrade” del mondo del lavoro. Vediamo a questo proposito cosa è successo in tal senso nel mondo che conosciamo meglio qui a bottega, quello del giornalismo. Gli autorevoli esperti della Fondazione Murialdi hanno aperto una fase di studio sul tema dello “smart working” chiamando a loro volta in causa alcuni luminari della professione, come ad esempio il direttore generale della Federazione Nazionale della Stampa, Giancarlo Tartaglia, dal cui intervento, isoliamo una serie di passaggi a nostro avviso particolarmente rilevanti:
forzata, cui siamo stati tutti costretti, ora che abbiamo nuovamente la possibilità di scegliere, non deve trasformarsi in una parentesi inutile e dannosa, bensì, in una utile fase di laboratorio da cui ricavare indicazioni importanti per realizzare un vero “upgrade” del mondo del lavoro. Vediamo a questo proposito cosa è successo in tal senso nel mondo che conosciamo meglio qui a bottega, quello del giornalismo. Gli autorevoli esperti della Fondazione Murialdi hanno aperto una fase di studio sul tema dello “smart working” chiamando a loro volta in causa alcuni luminari della professione, come ad esempio il direttore generale della Federazione Nazionale della Stampa, Giancarlo Tartaglia, dal cui intervento, isoliamo una serie di passaggi a nostro avviso particolarmente rilevanti:
In questi mesi i decreti governativi hanno cancellato diritti costituzionali fondamentali e hanno introdotto limiti allo svolgimento del lavoro, imponendo, laddove fosse possibile, il ricorso allo smart working.
Nella fase di emergenza nessun giornale ha interrotto la propria produzione. La libertà di stampa non è stata intaccata, ma tutti i giornalisti sono stati costretti a lavorare da casa: lo smart working ha regnato sovrano in tutte le redazioni e in alcuni casi si è rivelato, non una soluzione temporanea dovuta alla contingenza pandemica, bensì una prospettiva per il futuro. Qualche direttore-editore ha pensato che il futuro della professione giornalistica possa e debba identificarsi con lo smart working, cancellando le redazioni come luoghi fisici per la creazione quotidiana del giornale.
… il lavoro giornalistico non si svolge tutto e sempre nelle stanze della redazione. Il cuore di ogni giornale quotidiano è la cronaca e i cronisti svolgono la loro attività per le strade, nelle questure, negli ospedali, ecc., ovunque accadono fatti di cronaca di interesse generale.
I giornali, però, non sono fatti soltanto di cronisti. Vi sono molte altre mansioni, che svolgono principalmente la loro attività all’esterno.
Con lo sviluppo tecnologico e la possibilità di scrivere da remoto e trasmettere i propri “pezzi” in tempo reale alla propria redazione o addirittura direttamente in tipografia, si è iniziato ad utilizzare lo smart working anche per il lavoro tipicamente redazionale.
A questo punto è necessaria una riflessione. Il giornale, anche nella legge sul diritto d’autore, è considerato un’opera intellettuale collettiva. Collettiva non vuol dire che sia soltanto la somma di contributi individuali, ma che sia il frutto di una collettività redazionale. La redazione, nella produzione di qualsiasi giornale, è lo strumento fondamentale attraverso il quale passano la discussione e il confronto per arrivare alla elaborazione complessiva del prodotto che ogni giorno viene confezionato. Di conseguenza, la smaterializzazione della redazione, che si potrebbe tecnicamente realizzare con l’applicazione integrale dello smart working, potrebbe produrre un danno incolmabile al giornale stesso.
… nelle aziende editoriali di quotidiani e periodici, l’organizzazione del lavoro è di esclusiva competenza del direttore del giornale, sentito il Comitato di redazione. Ciò significa che l’organizzazione del lavoro non è mai di competenza del datore di lavoro, ovvero dell’editore. È questo il passaggio centrale del Contratto Collettivo di categoria e del lavoro giornalistico.
Ne consegue che lo smart working non può essere unilateralmente introdotto dall’azienda editoriale, né tanto meno contrattato individualmente tra azienda e singolo giornalista. Lo smart working deve essere previsto nell’organizzazione del lavoro, frutto del confronto tra direttore e Comitato di redazione.

Parole serie, di grande concretezza, lungimiranza e visione. Parole utili che vanno in una direzione molto precisa che sta dentro un alveo che presuppone caratteristiche professionali precise che corrispondano a diritti e doveri altrettanto precisi. Un ambito che non può essere affrontato solo facendo ricorso alla tecnologia – evidentemente – senza preoccuparsi di altro, come spiega molto bene Tartaglia. Il ragionamento sul lavoro a distanza che poi, piano piano, dovrebbe diventare per davvero “smart working”, non può non essere integrato ad un ragionamento più ampio sull’imprenditoria – non sempre e non solo i lavoratori a distanza sono dipendenti di un’azienda – , proprio in ambito giornalistico, questa modalità di lavoro, diventa sempre più importante per una nuova categoria di professionisti che ancora non sono nemmeno contemplati nel novero dell’attività professionale della categoria. Una forza lavoro che diventa sempre più grande, composta di professionisti, numerosi e ben inseriti nei ranghi della nostra professione, e che sono i cosiddetti “giornalisti imprenditori”. Il ragionamento – più difficile e certamente molto articolato – per il mondo del giornalismo, va – a nostro avviso – espanso a tutto il mondo imprenditoriale. Una parte consistente – sempre più corposa – del mondo del lavoro che già fa e farà in futuro, sempre più ricorso, al lavoro a distanza. Ne abbiamo parlato – in epoca non sospetta ed oramai quasi remota – in un nostro appuntamento digit di qualche anno fa. Estraiamo da quel dibattito del lontano 2015, due posizioni, diverse, e – allora come oggi – molto utili al confronto, quella di Carlo Bartoli – allora come oggi Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana – e di Marco Giovannelli – allora come oggi – co-fondatore e direttore di Varese News, un fulgido esempio italiano di quotidiano nativo digitale di successo, nonostante la crisi sempre più feroce dell’editoria, e l’incapacità del settore di completare la propria inevitabile transizione verso il digitale:
Carlo Bartoli:
La posizione dell’Ordine è fondamentale. Questo mutamento genetico ha enormi conseguenze anche per noi. L’ordine nasce come ordine di dipendenti ed effettivamente lo era sino a 30 anni fa. Rispetto alla figura del giornalista imprenditore ricordiamoci sempre la storica sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito il principio che nel giornalismo: << un ordine ci vuole perchè serve a garantire l’indipendenza del giornalista rispetto al contrapposto ruolo del potere economico rappresentato dall’editore >>.
Dice ancora la sentenza che tale ruolo di difesa non può essere assolto dal sindacato. In questo particolare momento che ruolo può svolgere l’ordine? Non possiamo essere difensori di una realtà che non esiste più. Le dinamiche professionali sono cambiate. Cerchiamo di aggiornarci e attraverso la formazione rendere competitivi i giornalisti ad un nuovo mercato del lavoro.
Marco Giovannelli:
La libera professione è una nobile cosa, una cosa che ha valore. Fare giornalismo significa però comprendere che il giornale è un’opera collettiva. Il tema deve tornare ad essere cosa significa fare un giornale anche come impresa. Il tema non può essere come posso sopravvivere ad un mercato che prevede le competenze da seo. Noi abbiam bisogno di capire che tipi di risposte ad una crisi così profonda e che riguarda la società possiamo dare come giornalisti non in quanto singoli ma come agenti di un’impresa collettiva e che solo come collettivo posso fare, che si chiama giornale. Dobbiamo rispondere alla domanda su come fare informazione oggi. Al centro va messa la forma di lavoro collettivo che è un giornale. Applaudo chi fa crowdfunding. Ma un po’ mi fido e un po’ no. Perchè qualunque cosa succeda solo uno ne risponde. Un editore garantisce un processo collettivo di costruzione di un processo informativo.
La forma giornale è soprattutto a tutela del lettore. Non è che il comunicatore è un truffaldino e il giornalista è un santo. Pensate a Eni che ora ha la parte della comunicazione diretta da un grande giornalista come Marco Bardazzi. Non ci sono contrapposizioni su questo. Il concetto è molto diverso. Eni ultimamente proprio sui mezzi digitali sta facendo ottimo giornalismo e anche giornalismo di sperimentazione inteso come forme narrative.
Come vedete, la posizione di Marco Giovannelli allora, era in forte sintonia, con quella delle istituzioni del giornalismo, nella fattispecie espressa da Carlo Bartoli, ma anche, soprattutto, era già allora, in quasi totale accordo con quella attuale del direttore generale della FNSI Giancarlo Tartaglia. Un pensierino forse andrebbe fatto sulla questione, che ne dite? Visto che già allora eravamo tutti in pesante crisi. Visto che nel frattempo sono passati altri 5 anni. E visto che la situazione dei giornali e dei giornalisti, nel frattempo, non è certo andata migliorando. E che dire dei diritti dei lavoratori? Lavoratori che nel frattempo si sono trasformati – secondo la nostra personalissima interpretazione – in riders, quasi tutti, non solo i componenti del comparto dell’informazione. Prima di procedere verso chissà quali riforme bisognerebbe forse fare mente locale e ricordare a tutti che nel “dorato” mondo della trasformazione digitale, al posto degli “smart worker” spesso e volentieri ci ritroviamo non “agili lavoratori del futuro” ma novelli schiavi del presente. Persone sfruttate ad ogni piè sospinto. Senza diritti, con doveri pesanti e onerosi, sovente impossibili da realizzare. Persone non garantite: proprio come i riders, purtroppo. Braccianti digitali – come li ha definiti molto bene, il nostro, Marco Dal Pozzo in un suo recente articolo – persone che assomigliano molto, ai Turchi Meccanici, dell’800. Persone sempre più utilizzate e sfruttate alla bisogna, dentro le poderose e onnipresenti techno corporation dette anche meta nazioni digitali.
Un lavoro – apro una parentesi che penso sia utile per sostanziare il pensiero – che può contare su alcune inchieste già disponibili, penso per esempio a quello di Riccardo Staglianò nel suo “Lavoretti”. Un’altra è quella di Massimo Gacci sul Corriere, un interessante pezzo del Corriere dello scorso 26 Maggio dal titolo “I braccianti digitali al servizio dei robot”: alle categorie individuate da Staglianò, aggiunge quella degli sharecropper (che letteralmente vuol dire proprio coltivatore, mezzadro): si tratta di lavoratori invisibili, un po’ come quelli che fanno da content moderator (di cui in effetti Staglianò aveva parlato evidenziando anche le patologie traumatiche di cui possono rimanere vittime), che etichettano le immagini per istruire al riconoscimento con i meccanismi del machine learning le intelligenze artificiali. La loro dinamica di retribuzione li rende assolutamente al pari livello dei braccianti agricoli descritti da Aboubakar Soumahoro: le società di etichettatura – dice Gaggi, nella sua corrispondenza da New York – sostengono di pagare i loro collaboratori da 7 a 15 dollari l’ora, ma in realtà le retribuzioni medie sono molto inferiori, anche perché gran parte di queste mansioni elementari sono affidate a lavoratori a basso costo africani e asiatici. Attualmente, ricorda Gaggi, i maggiori bacini per il labeling sono in Kenya e Malaysia dove le retribuzioni in genere vanno dai 3 ai 5 dollari l’ora.
Vanno dunque definite le mansioni, vanno compresi i nuovi diritti e i nuovi doveri di questi lavoratori a distanza, vanno stabiliti i criteri di sicurezza per rendere adeguato il proprio ambiente domestico all’attività lavorativa. Va preso atto del percorso storico, sindacale, legislativo e umano che il lavoro e i lavoratori hanno tracciato nel corso degli anni, spesso a costo della loro stessa incolumità. E questo percorso di diritti e di doveri costato sangue, sudore e lacrime, non può e non deve essere ignorato seguendo un’idea alternativa e fintamente progressista che propone soluzioni riduzioniste a problemi reali come se fossero invenzioni innovative e in linea con il “progresso” digitale. Il lavoratore casalingo da terminale, che passa anche 24 ore davanti ad un terminale, per guadagnare 10 o 20 dollari in un giorno, non può in alcun modo essere definito uno “smart worker”, ma nemmeno un “worker”, è certamente uno schiavo. E quando ci viene fatto notare che nei paesi in cui questi schiavi della tastiera svolgono il proprio operato, queste cifre rappresentano molto più della media dei guadagni dei “lavoratori normali”, non  possiamo in alcun modo sentirci consolati o peggio gratificati dall’azione delle multinazionali hi tech che sovrintendono questo specifico tipo di sfruttamento del lavoro. Siamo tutti indignati con le multinazionali che fanno cucire i vestiti, o confezionale le scarpe, ai bambini del terzo mondo per pochi dollari – anche se sono relativamente tanti in quei paesi – perchè non dovremmo ugualmente indignarci contro lo sfruttamento indiscriminato dei “mechanical turk”? Assieme poi ai diritti dei lavoratori, questione come abbiamo visto, ancora più stringente e centrale in questo mondo che va verso una sempre più evidente – ma ingiustificata – deregulation, troviamo la questione dei dati. Lasciamo perdere le mode e le definizioni altisonanti. Big o small, i dati sono il problema centrale della nostra epoca. E la questione, oltre a essere disattesa e male interpretata dalla maggior parte di noi, non sempre – anzi quasi mai – viene gestita nel modo corretto nel mondo del lavoro. E non si tratta solo di mancanza di personale competente per svolgere nel modo corretto le mansioni necessarie. I dati che diventano informazioni o che sono informazioni, i dati che si accumulano senza tregua e spesso senza una ragione, i dati che sostituiscono i processi, che sostituiscono le procedure, che sostituiscono i controlli e le verifiche. Costituiscono un problema strutturale per la nostra società. Come dice molto bene il sociologo della complessità Piero Dominici: i dati non sono e non possono essere dati di fatto. E invece lo diventano, sempre più spesso. E queste procedure, innescano meccanismi di impoverimento progressivo dell’umana conoscenza, non il contrario. Un problema davvero stringente sul quale torneremo molto presto. Intanto per inserire alcuni parametri corretti nella questione del lavoro a distanza e della gestione dei dati – a distanza – proviamo ad avvalerci del parere di un esperto: l’analista dei dati Luca Corsato che su smart working e dati ha recentemente pubblicato un proprio contributo, da cui estraiamo alcuni passaggi:
possiamo in alcun modo sentirci consolati o peggio gratificati dall’azione delle multinazionali hi tech che sovrintendono questo specifico tipo di sfruttamento del lavoro. Siamo tutti indignati con le multinazionali che fanno cucire i vestiti, o confezionale le scarpe, ai bambini del terzo mondo per pochi dollari – anche se sono relativamente tanti in quei paesi – perchè non dovremmo ugualmente indignarci contro lo sfruttamento indiscriminato dei “mechanical turk”? Assieme poi ai diritti dei lavoratori, questione come abbiamo visto, ancora più stringente e centrale in questo mondo che va verso una sempre più evidente – ma ingiustificata – deregulation, troviamo la questione dei dati. Lasciamo perdere le mode e le definizioni altisonanti. Big o small, i dati sono il problema centrale della nostra epoca. E la questione, oltre a essere disattesa e male interpretata dalla maggior parte di noi, non sempre – anzi quasi mai – viene gestita nel modo corretto nel mondo del lavoro. E non si tratta solo di mancanza di personale competente per svolgere nel modo corretto le mansioni necessarie. I dati che diventano informazioni o che sono informazioni, i dati che si accumulano senza tregua e spesso senza una ragione, i dati che sostituiscono i processi, che sostituiscono le procedure, che sostituiscono i controlli e le verifiche. Costituiscono un problema strutturale per la nostra società. Come dice molto bene il sociologo della complessità Piero Dominici: i dati non sono e non possono essere dati di fatto. E invece lo diventano, sempre più spesso. E queste procedure, innescano meccanismi di impoverimento progressivo dell’umana conoscenza, non il contrario. Un problema davvero stringente sul quale torneremo molto presto. Intanto per inserire alcuni parametri corretti nella questione del lavoro a distanza e della gestione dei dati – a distanza – proviamo ad avvalerci del parere di un esperto: l’analista dei dati Luca Corsato che su smart working e dati ha recentemente pubblicato un proprio contributo, da cui estraiamo alcuni passaggi:
Il mercato degli uffici è in stallo da anni, mentre quello dei negozi è in caduta libera. Prima si diceva della crisi del 2008, poi dei centri commerciali, poi dei BnB che escludevano servizi dai centri città. Il punto è che i costi degli spazi è rimasto sempre alto e l’accesso ai servizi sempre più basso.
L’esercente quindi è tra due fuochi, la contrazione dei clienti e l’aumento delle spese. Questo però non è a causa del lockdown, ma esisteva da prima.
Lo smart working ha ridotto i movimenti delle persone, o almeno di molte categorie. Chi non si è mai fermato sono stati i Rider. Inevitabilmente si sono potenziati i servizi di consegna, e per molti è stata un’attivazione da zero. Ora l’esperienza di accesso e acquisto avviene via digitale, tagliando il valore offerto dal contatto personale e dai locali.
Nel mio piccolo ho parecchi casi di esercizi che usando le consegne in autonomia hanno salvato le proprie attività. Tutti questi esercizi hanno locali in zone periferiche, quindi con costi di affitto più bassi e meno vincoli per il parcheggio e la circolazione dei mezzi propri. Soprattutto però hanno spostato il valore della relazione con lo spazio – il negozio, l’azienda agricola, il ristorante – sulla consegna mantenendo il valore della relazione con la persona.
Qui viene la mia parte. I vari esercenti si sono accorti che ricordarsi a mente tutte le varie personalizzazioni quando hai un negozio è facile, ma con il primo contatto basato sul digitale è più difficile.
IL VALORE AGGIUNTO SONO I DATI, O MEGLIO, IL LAVORO SUI DATI PER TRASFORMARLI IN VALORE
È su questo che le categorie dovrebbero lavorare: aiutare i propri associati a estrarre quei dati, aggregarli e presentare richieste di agevolazioni al decisore politico e pubblico.
Il mestiere di lobbing è difficile, ma se lo si fa senza dati è solo un’attività mirata alla conservazione, lasciando spazi ad altri soggetti che si prendono tutte le posizioni senza nemmeno faticare. Per informazione chiedere ai giornali o ai cocchieri.
Non parliamo più di smart working per favore, non come si è fatto fino ad ora, e senza un progetto a medio lungo periodo che ci orienti e ci consenta per davvero di trasformare il mondo del lavoro, aggiungendo questa eccellente risorsa a quelle già in nostro possesso. E intanto che ci siamo, mettiamoci pure tutti insieme, e di gran lena, a lavorare, per trasformare questa nostra società in crisi, reduce da una pandemia devastante e purtroppo non ancora sotto controllo, e alle prese con la trasformazione da analogica a digitale, e oppressa dal trovare un ruolo all’animale uomo messo sempre più sotto pressione dalle macchine, i robot, e le intelligenze artificiali: in una società equilibrata, a misura d’uomo, dove le competenze e gli errori “umani”, torneranno a giocare un ruolo determinante, e ci permetteranno di ritrovare i valori, quelli indispensabili, per poter ambire alla felicità e al benessere di ciascuno di noi.

