
Sullo stato del giornalismo
 In questa ” conversazione ” di Raffaele Fiengo, registrata e pubblicata da noi in forma integrale durante una sua “lezione” pubblica per giornalisti (e non) organizzata nel giugno scorso dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia cui ha partecipato anche Claudio Giua, il fondatore, assieme a Pino Rea, di questo gruppo di lavoro sul giornalismo che si chiama Libertà di stampa diritto all’informazione (lsdi) racconta attraverso lo studio e la presentazione di una serie di esempi “virtuosi” la fenomenologia del cambiamento in atto nel mondo del giornalismo “globale” dovuta solo in parte all’avvento della rivoluzione digitale e alla diffusione dei media online. Fiengo inizia la sua esposizione partendo da due ricerche di settore assai importanti per il “presente” del giornalismo: la prima si intitola “Overload” ed è stata realizzata circa un decennio or sono dai ricercatori universitari della Columbia in patnership con i giornalisti dell’Associated Press e la seconda si chiama “Innovation” ed è un documento interno di programmazione del New York Times divulgato in parte, come fosse un vero e proprio scoop, dal blog di “gossip e notizie” americano BuzzFeed in prima battuta e poi pubblicato integralmente da Mashable.
In questa ” conversazione ” di Raffaele Fiengo, registrata e pubblicata da noi in forma integrale durante una sua “lezione” pubblica per giornalisti (e non) organizzata nel giugno scorso dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia cui ha partecipato anche Claudio Giua, il fondatore, assieme a Pino Rea, di questo gruppo di lavoro sul giornalismo che si chiama Libertà di stampa diritto all’informazione (lsdi) racconta attraverso lo studio e la presentazione di una serie di esempi “virtuosi” la fenomenologia del cambiamento in atto nel mondo del giornalismo “globale” dovuta solo in parte all’avvento della rivoluzione digitale e alla diffusione dei media online. Fiengo inizia la sua esposizione partendo da due ricerche di settore assai importanti per il “presente” del giornalismo: la prima si intitola “Overload” ed è stata realizzata circa un decennio or sono dai ricercatori universitari della Columbia in patnership con i giornalisti dell’Associated Press e la seconda si chiama “Innovation” ed è un documento interno di programmazione del New York Times divulgato in parte, come fosse un vero e proprio scoop, dal blog di “gossip e notizie” americano BuzzFeed in prima battuta e poi pubblicato integralmente da Mashable.
Ecco alcuni estratti dalla lezione di Fiengo e buona lettura. In coda al documento trovate il video integrale dell”intervento del Professore.
” L’impresa giornalistica non è che sta subendo una trasformazione l’ha già subita ed è stata trasformata prevalentemente in un’impresa di comunicazione. Questo fatto può essere individuato anche in alcuni documenti e in alcune carte e in alcuni specifici fatti, accaduti negli ultimi anni, che esamineremo come casi specifici durante questo nostro incontro.
I risultati di questo cambiamento talvolta sono sconcertanti. L’ingresso della pubblicità direttamente nei contenuti dei giornali – circostanza che si sta pienamente realizzando proprio in questi ultimi anni – è uno dei fenomeni più complessi e che meritano approfondimento e studi, ma sebbene problematico, penso che anche questo possa avere una certa utilità.
Iniziamo l’esame di questo cambiamento partendo da un documento uscito circa una decina di anni fa. Un rapporto denominato “overload” pubblicato sulla rivista della Columbia University. Una bella ricerca condotta dai ricercatori universitari assieme ai giornalisti dell’Associated Press che definiva il giornalismo come una sorta di rumore indistinto, una grande confusione dove era diventato molto difficile distinguere i fatti veri dal rumore di fondo. Come ascoltare in modo molto disturbato un canale radiofonico. Dalla ricerca emergeva chiaramente che il ruolo del giornalismo era passato da essere “gate keeping dei flussi” alla contestualizzazione e alla capacità di dare un senso a questa massa sempre più ingente di informazioni indistinte che affollano soprattutto il web. Questi dati arrivavano nel bel mezzo di una pesantissima crisi del comparto editoriale, crisi che stiamo tuttora vivendo, con la caduta verticale delle entrate pubblicitarie e il calo progressivo e inarrestabile delle vendite dei prodotti cartacei.
Due anni fa il New York Times ha preparato un rapporto interno, che poi è stato reso pubblico, denominato “innovation”. Un lavoro di analisi con una serie di proposte operative per “svecchiare” il gruppo editoriale, realizzato da un gruppo selezionato di esperti del settore, che doveva rimanere riservato. Il rapporto è stato consegnato nella primavera del 2014. Alla redazione della ricerca hanno partecipato i figlio dell’editore, vice-capo cronista, un senior video journalist, un assistant editor del mobile, un giornalista investigativo, un giornalista del business, un giornalista esperto in tecnologia, un grafico esperto di impaginazione, un manager delle strategie editoriali, fra questi anche due premi Pulitzer. Quindi un gruppo altamente qualificato.
Il valore di questo documento, è doppiamente importante, sia per la qualità delle persone che ci hanno lavorato, sia perché era un documento strategico interno del giornale e quindi molto più essenziale e diretto; l’intento del documento, come abbiamo accennato, doveva essere: adeguare al mondo digitale la newsroom riluttante e troppo focalizzata sulla prima pagina stampata delle testate.
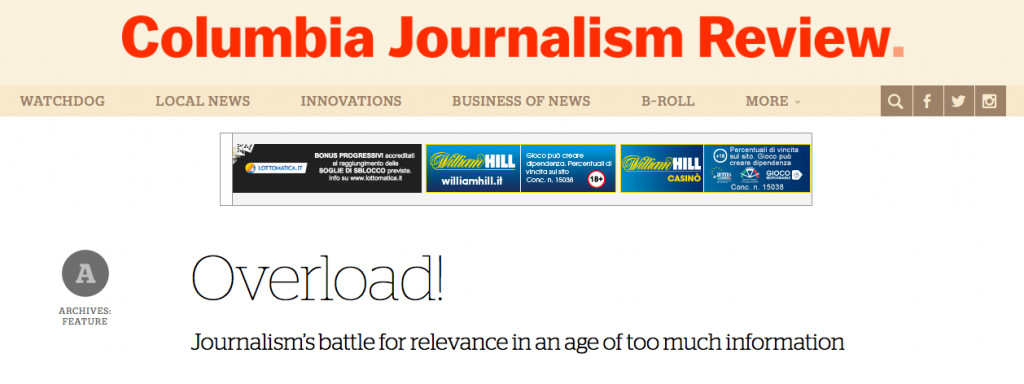 Buzzfeed sito americano di giornalismo, chiamiamolo “disinvolto”, rispetto al mercato e anche ridondante, gattini compresi, ha pubblicato per primo questo rapporto interno riservato del Nyt, privo di alcune parti. Mashable lo ha ripubblicato in seguito completo.
Buzzfeed sito americano di giornalismo, chiamiamolo “disinvolto”, rispetto al mercato e anche ridondante, gattini compresi, ha pubblicato per primo questo rapporto interno riservato del Nyt, privo di alcune parti. Mashable lo ha ripubblicato in seguito completo.
A pagina 62 ci sono alcune affermazioni davvero importanti, probabilmente in base a quello che viene detto, il direttore stesso del giornale Jill Abramson, ha deciso di dimettersi. Affermazioni che definiscono il cambiamento e lo spiegano.
Nel documento si legge testualmente: Il muro che separa la newsroom dal business ha servito il giornale per decenni permettendo ai giornalisti di relazionarsi con i lettori e al commerciale di pensare agli azionisti. Ma la costante diminuzione della pubblicità ora ci chiede di lavorare insieme. Per la prima volta newsroom e business sono focalizzati entrambi sui lettori. Ma il vero primo passo deve essere una decisa spinta per abbandonare il muro, la metafora delle separazione fra chiesa e stato, che vuole la necessità di agire separatamente e tenere distinti i due settori. Un incremento della collaborazione fra le due anime del giornale non rappresenta alcuna minaccia per i nostri valori di giornalismo indipendente.
Una bomba.
Primo effetto: la cacciata di Jill Abramson, che pure aveva contribuito non poco a difendere il New York Times nella crisi di trasformazione dei giornali. E la sua sostituzione con Dean Baquet.
Dopo l’estate, il 24 settembre 2014, una notizia in apparenza lontana dalle questioni in campo: il “New York Times” abolisce la figura del Managing Editor, capo operative della Newsroom, e introduce quattro vicedirettori “per area”. E’ la nuova organizzazione per creare rapporti più stretti con i settori non giornalistici dell’azienda. Twitto un veloce commento: “The Wall is falling!”. Un giornalista del NYTimes lo mette tra i “preferiti”. E’ proprio così: il muro sta cadendo.
Ken Auletta sul “NewYorker” intitola “Perchè è stata licenziata” e dice senza mezzi termini che il Native Ad è uno dei fattori. Tutto porta a pensare questo. Qualche mese prima la Abramson aveva accettato la pubblicità nativa sul sito del New York Times, ma aveva voluto su ogni articolo sponsorizzato la chiara indicazione della diversa genesi. Che si tratti di una questione delicata ormai è sicuro. Nel 2013, lunedì 14 gennaio poco dopo mezzogiorno, il prestigioso mensile “The Atlantic” era caduto in un incidente incredibile: aveva pubblicato un “Advertorial” (brutto termine che inquina anche linguisticamente il nobile “Editorial”) attorno ai successi di Scienthology, la assai discussa e ancora potente setta. Le reazioni sono state così forti che “The Atlantic”, dodici ore dopo, ha dovuto togliere il testo dalla sua edizione online. Non solo, ma inizialmente, per difendere la sua discutibile scelta, aveva anche censurato i commenti negativi che arrivavano in gran quantità. Un naufragio.
“The Atlantic” ha ufficialmente fatto ammenda: “E’ stato permesso al marketing di moderare i commenti censurando le critiche” e si è scusato con i lettori per l’incidente avvenuto “nella ricerca di nuove forme di pubblicità”. Il sito satirico “The Onion” ha sottolineato la gaffe con un falso “advertorial” “sponsorizzato dai Talebani, un nuovo vibrante e prospero movimento”.
Nel rapporto “innovation” non solo viene messa in evidenza la pubblicità destinando particolare attenzione alle forme di “native advertising” ma si parla molto anche di social network.
Che la pubblicità nativa, con i connessi primati del marketing e dei socialnetwork, sia l’arcata principale del nuovo modello di business dell’impresa giornalistica non credo vi siano dubbi.
Una certa vaghezza circonda anche il termine “pubblicità nativa”. In sostanza le aziende sembrano stanche di propagandare i propri prodotti con inviti diretti all’acquisto. Cercano di proporre invece contenuti nel linguaggio degli spazi credibili dei media. Ingaggiano giornalisti, ma non tanto per uffici stampa quanto per usarli in quanto tali. Una indagine del giugno 2014, condotta dall’ Università di Padova (autore Marco Bettiol professore di marketing avanzato) e dalla Fondazione Nord-Est, su 200 laureati magistrali di Comunicazione degli ultimi dieci anni (hanno risposto 165 su 271, sembra confermare il terreno che il giornalismo sta perdendo. Ha un lavoro l’88 per cento (35% a tempo indeterminato, 31 % a termine, 11% freelance, 8% a progetto). Ma i quattro ambiti più diffusi in cui lavorano i laureati sono: marketing e comunicazione, web e social media, pubblicità, vendita e commerciali. L’informazione e l’editoria rappresentano soltanto il quinto ambito lavorativo per diffusione.
Colpisce il caso della CocaCola che, Babbo Natale a parte, scava sulla sua linea della felicità fino a servirsi anche dell’”inchiesta”. Nella primavera del 2014, – Vahuni Vane ne ha scritto il 15 marzo 2014 sul “NewYorker” in “CocaCola’s happiness machines”, – ha creato uno spot che, nella parte narrativa, potrebbe competere con i servizi di Riccardo Iacona di “Presa diretta”. Emigrati pakistani e indiani, sfruttati a Dubai, ripresi all’alba mentre vanno al lavoro per 6 dollari al giorno. Nelle interviste la nostalgia per la famiglie amate e lontane. Nemmeno al telefono possono sentire le mogli e i figli. Un minuto costa un dollaro. Schermo rosso. E poi…
“So what if every coke come with a few extra minutes of happiness”.
Nei cantieri sono installate cinque cabine con telefoni, non funzionano con i soldi, ma con i tappi di CocaCola. Tre minuti di chiamata internazionale. Ogni lattina costa 45 cents. “Un decimo della paga giornaliera, odioso!” osserva giustamente scandalizzato Nicholas McGeehan, ricercatore di Human Rights Watch. Ma telefonano 40.000 persone. Poi la CocaCola smantella tutto.
Propaganda sulle spalle dei poveri disgraziati, pubblicità progresso, giornalismo migrato e venduto? Nuova forma di due soggetti da sempre nell’impresa giornalistica – giornalismo e pubblicità – ora divenuti due compari? Che cosa è?
Ritornando al Nyt che cosa altro è accaduto dopo l’applicazione di “innovation”? Le conversazioni sui social entrano da protagoniste nella realizzazione del giornale attraverso il meccanismo che loro definiscono “readers speedness” come una sorta di auditel che detta l’agenda. Il senso comune che viene fuori dalle conversazioni delle persone attraverso i social è recepito dalla redazione e diventa primario per la realizzazione del giornale.
L’esempio del Nyt definisce bene il cambiamento in atto nel mondo del giornalismo. Pensate alla strage di Srebrenica, 8000 morti, che, per la stampa italiana, visto che la ex Yugoslavia non faceva audience secondo l’auditel, non abbiamo mai visto o quasi.
Ecco in quest’epoca non è più così e l’equilibrio dei flussi di informazioni, a cominciare proprio da quello che è successo al Nyt, si basa sull’incorporazione delle conversazioni delle persone attraverso i social nella gerarchizzazione delle notizie dei quotidiani.
In tutto questo non è che il giornalismo sia andato via, ha subito come un contraccolpo. Ma il giornalismo non è solo parte integrante del business di un giornale è anche, ed è bene sottolinearlo, parte integrante dell’assetto democratico di un Paese.
Al Corriere della Sera poco prima del cambio di direttore dopo le dimissioni di Ferruccio De Bortoli, proprio De Bortoli mi fece leggere un documento interno e riservato, che prevedeva la riorganizzazione del giornale sulla stessa falsariga dell’operazione condotta al Nyt. La risposta che De Bortoli diede al documento è stata in buona parte positiva sottolineando però la necessità di mantenere separato e indipendente dal business il ruolo dei giornalisti e del giornalismo. Questo documento che non è mai stato reso pubblico, modifica alcuni aspetti fondanti della professione giornalistica. Ad esempio cambia l’art 6 delle legge istitutiva della professione che definisce l’autonomia e il ruolo del direttore responsabile. Lo peggiora, cancellando quasi del tutto le mansioni autonome del direttore. Del resto in Italia siamo purtroppo molto indietro su questi temi, non a caso nell’ultimo rapporto sulla libertà di stampa nel mondo siamo al 77esimo posto. E non è neppure un caso che solo ora e dopo un dibattito non così tanto evidente nella società civile si sia riusciti a indurre il Governo a promulgare una legge che istituisca un Freedom of Information Act anche in Italia. I problemi sono ancora molti e le cose non sembrano migliorare per la nostra professione. Mentre invece ci si dimentica che il compito precipuo del giornalismo è quello di moltiplicare la conoscenza.

