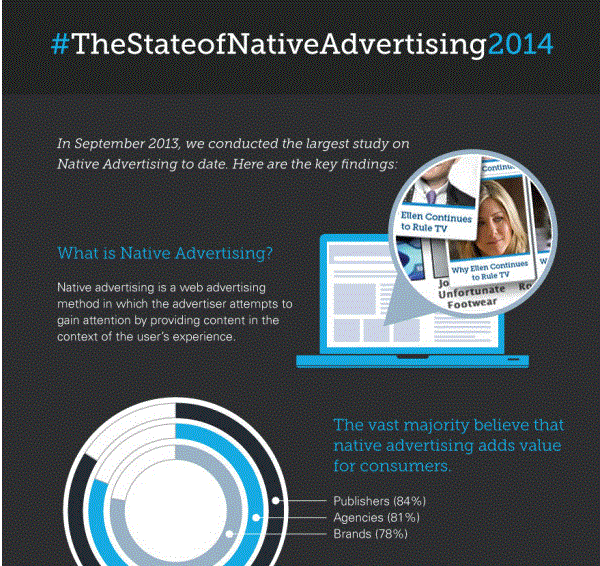Native advertising: grandi speranze (economiche), acque (giudiziarie) agitate e dubbi (etici)
 Mentre negli Stati Uniti Wikipedia ha denunciato una nota agenzia di relazioni pubbliche che ha violato il codice di condotta pubblicando una serie di articoli e chiedendo ai suoi clienti un compenso monetario, sul fronte del ‘’native advertising’’ (contenuti a pagamento identici ai contenuti redazionali), ora al centro di una fortissima attenzione dell’ industria giornalistica, comincia a tirare aria di interventi giudiziari anche in Australia.
Mentre negli Stati Uniti Wikipedia ha denunciato una nota agenzia di relazioni pubbliche che ha violato il codice di condotta pubblicando una serie di articoli e chiedendo ai suoi clienti un compenso monetario, sul fronte del ‘’native advertising’’ (contenuti a pagamento identici ai contenuti redazionali), ora al centro di una fortissima attenzione dell’ industria giornalistica, comincia a tirare aria di interventi giudiziari anche in Australia.
Un importante studio legale di Sidney non esclude infatti la possibilità di citare in giudizio qualche testata (e qualche brand) accusandola di ingannare i consumatori, annuncia il sito australiano Adnews.
Il gruppo Fairfax dispone già di una piattaforma per il native ad, mentre la News Corp sta cominciando a sperimentarla e il MailOnline ha detto che ’’sicuramente’’ farà del ‘native ad’ quando sarà lanciato in Australia il prossimo anno.
Qualcuno parla solo di ‘’advertorial’’ (pubbliredazionali), altri di content marketing, in ogni caso – spiega Adnews – il native advertising viene considerato come una potente fonte di nuove entrate, per i media sia online che offline . L’ idea è che i consumatori rispondano in maniera più favorevole a dei contenuti utili piuttosto che a una pubblicità invasiva.
Proprio in questi giorni comunque la US Federal Trade Commission ha ammonito che il native advertising può essere illegale se i consumatori non sono stati avvertiti in maniera chiara che si tratta di contenuti sponsorizzati.
E anche nel nostro paese resta il principio, sancito dalla legge (il codice del consumo) e dal principale contratto di lavoro giornalistico (quello Fieg-Fnsi), secondo cui i contenuti pubblicitari devono essere facilmente riconoscibili.
Il fatto è che, secondo eMarketer, tra l’ altro, quest’ anno gli investimenti in native advertising cresceranno del 44,7%, raggiungendo il 5,6% della spesa pubblicitaria totale, 2.3 miliardi di dollari nel 2013, come riportava qualche giorno fa Italiaoggi.it.
Si tratta di un fenomeno di grande ampiezza e di evidente interesse economico.
Lo confermano i dati contenuti in una bella infografica dedicata proprio a ‘’The State of Native advertising 2014’’, consultabile qui.
L’ entusiasmo, soprattutto negli Stati Uniti, ha portato alla diffusione di una serie di convinzioni (molte delle quali leggende metropolitane) sul native che qualche giorno fa su Digiday un esperto, Josh Sternberg, ha analizzato, cercando di sfatare i miti e ristabilire la ‘’verità’’.
– Il native ad è una novità? Falso!
– Non si può fare del native ad in maniera scalare? Assolutamente falso!
– Ciascun brand può fare i suoi contenuti in native ad? Vero!
– Il native ad funziona sul lungo periodo? Assolutamente sì.
E così via.
«È necessaria chiarezza», dice Simona Zanette, presidente di Iab Italia, l’associazione dedicata all’advertising interattivo, secondo quanto riporta Italiaoggi.it. «Bisogna cercare di stare fuori il più possibile dalla trappola di far credere all’utente che si tratti di contenuti non pubblicitari. Deve essere chiaramente evidenziato. Ed è un lavoro che richiede la presenza forte degli editori, anche perché in un certo senso si mette nelle mani altrui il proprio prodotto».
Osservava Luca Sofri qualche giorno fa su Wittgenstein:
Se volete la mia, la risposta è no: non si può cedere sul terreno della chiara e trasparente distinzione senza perdere qualità, con quello che implica la perdità di qualità dell’informazione, fino al suo ruolo nel funzionamento delle democrazie e delle comunità. Ma se volete la mia, questo è anche sempre avvenuto e avviene oggi quotidianamente nei giornali che leggiamo. Non parlo dell’esteso mondo delle “marchette”, che pure esiste ed è esteso. Ma dove una volta si era inventato il “pubbliredazionale” – articoli pubblicitari uguali a quelli giornalistici, ma con la dicitura “pubbliredazionale” che avvisava il lettore – oggi è saltata la dicitura e quegli articoli occupano pagine intere e inserti completi: “speciali”, “eventi”, eccetera.
Per non dire degli articoli appositamente compilati per compiacere gli inserzionisti, per dar loro un contesto in cui inserire le loro pubblicità, per compensare il loro investimento con un di più di citazioni di prodotti. È il caso di quelle pagine di “costume o “stili di vita” che sui giornali esibiscono prodotti scelti nel contesto artificioso di un presunto “fenomeno” o “tendenza”, o di “recensioni”; o dei “siti verticali” dedicati a categorie di prodotti che attraggono pubblicità.
Quindi, se volete la mia, la cosa da temere non è una maggior presenza sui media – tradizionali e non – di contenuti pubblicitari non motivati da ragioni di informazione o rilevanza della notizia: quelli sono ciò che hanno sempre sostenuto gran parte dell’informazione e del giornalismo che abbiamo sempre apprezzato. La cosa da temere – e già dilagata – è la mancanza di chiarezza nei confronti del lettore sulla differenza tra le une e le altre cose che legge. È la scomparsa della dicitura “pubbliredazionale” e della distinzione.
L’ ondata di ‘’entusiasmo’’ che circonda il ‘’native advertising’’ mette in allarme anche la Ferpi, la Federazione delle associazioni di relazioni pubbliche.
In questi giorni, racconta Gabriele Cazzulini sul sito della Federazione,
Wikipedia ha denunciato il comportamento formalmente scorretto di una nota agenzia di relazioni pubbliche statunitense, che ha violato il codice di condotta di Wikipedia pubblicando una serie di articoli e chiedendo ai suoi clienti un compenso monetario.
Ma ci sono casi più gravi, dove esistono intere “content farms” che creano e pubblicano, in modo quasi totalmente automatico, ammassi di contenuti di bassa qualità ma fortemente ottimizzati per essere trovati su Google – e questi ammassi di contenuti scadenti e promozionali diventano a loro volta spazi enormi per raccogliere inserzioni pubblicitarie ancora più scadenti. Così si intasa il web e si inondano gli utenti con liquami di contenuti “fake”, finti e puramente congegnati per attirare click in modo fraudolento.